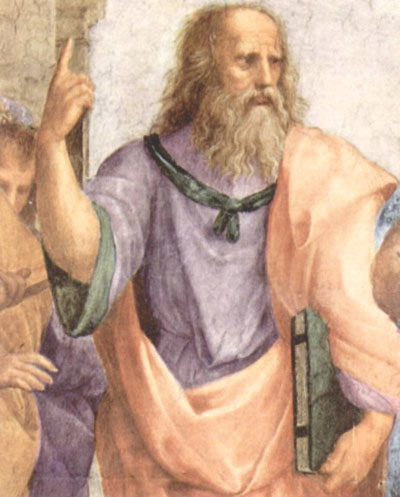Reich e Gurdjieff
di David Brahinsky
in corso di pubblicazione per Spazio Interiore
previsto per Dicembre 2014
All’interno de I racconti di Belzebù a suo nipote, [1] a un certo punto il protagonista condanna l’uomo moderno e lo rimprovera duramente per non essere riuscito ad adempiere ai partk/dolg/doveri esserici, tanto da considerare questo fallimento come una malattia, dal momento che per lui il lavoro cosciente e la sofferenza volontaria costituivano la naturale e sola funzione che l’essere tricerebrale maturo manifestasse. Ma se sono così naturali, perché allora l’uomo odia tali pratiche? Perché odia intraprendere un percorso necessario all’evoluzione del proprio essere?
Lo studio di Reich fornisce una risposta alla questione di cui sopra: odiamo fare qualsiasi cosa sia necessaria per proseguire il nostro sviluppo perché sin dall’infanzia, e poi anche nell’adolescenza, proprio le funzioni primarie che ci contraddistinguono sono state represse. Ci è stato insegnato a temere l’evoluzione creativa, ad aver paura del libero fluire dell’energia orgonica all’interno del nostro corpo, e da queste paure è nata la corazza. Essa ci rende pigri, ci frammenta internamente in diversi “io” e ci impedisce di assimilare le impressioni legate all’evoluzione. Quando impressioni di tal genere, infatti, sono disponibili in un individuo molteplice, pigro, arrabbiato, frustrato, pauroso, represso, apatico, pieno di desideri infantili, che rigetta le idee del Lavoro, queste non possono essere assimilate in modo adeguato e pertanto si rivelano inutili. L’elemento alla base di questo processo, che è volto a reprimere la capacità di evolvere, consiste nella soppressione della sessualità, cioè di quella funzione base della creatività che sta all’origine dei processi creativi dell’evoluzione, prevista peraltro in ogni piano dell’esistenza.
Ora, se l’analisi sin qui condotta è esatta, il ripristino di questa funzione svilupperebbe nell’individuo la capacità di introdurre le impressioni tramite il secondo shock cosciente, impressioni che vengono registrate all’interno del centro emozionale superiore come “sentimento religioso”, “sacralità o divinità di ogni cosa che esiste” e, al contempo, “rimorso di coscienza”. Questa descrizione sottintende che le impressioni sono contraddistinte da un amore fortemente radicato nei confronti di tutti gli esseri, un sentimento così straordinario e onnicomprensivo che comporta il pieno sentire; pochi, oltre ai santi, sono in grado di provarlo. In effetti, c’è da chiedersi come possiamo noi, che ci lamentiamo continuamente per questioni riguardanti il tempo, i vicini, i politici, le tasse e via dicendo, giungere a provare un sentimento di tali proporzioni. Alcune religioni si fanno portatrici di tale messaggio, sebbene non sia poi automatico che esso venga incarnato da coloro che ne seguono i dettami.