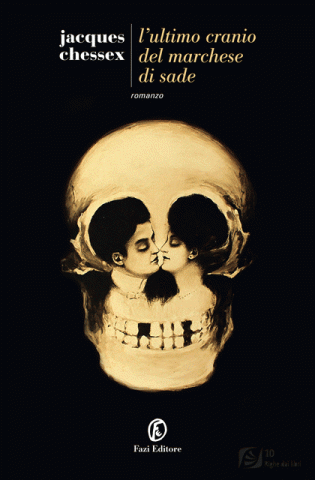Sono il poeta della donna come dell’uomo,
e dico che è grande essere donna come essere
uomo e dico che non c’è niente di più grande
che la madre degli uomini.Walt Whitman
Il mito è chiaramente il luogo in cui l’essere, incontrando il divenire, dà forma ad un cosmos simbolico, dove la passione, spesso, ha l’aria d’essere un’idolatria e l’illusione è il dio terapeutico idolatrato capace di rimuovere l’infelice pathos, prospettando un felice ethos.
Esso è quindi filosofia che raccoglie il primitivo ingenuo filosofare per innestarlo in quello che segue, dove i mithologhemi[1] diventano filosofemi che, rispecchiando l’incremento problematico dell’esser-ci e le sue implicazioni poilitiche[2] mirano a cogliere la individualità essenziale della realtà ed a spiegarne la immutabile verità, aiutando l’anima a volgersi da un giorno tenebroso ad un giorno vero[3].
Va detto che i mithologhemi, che pure possono avere di si per sé, soprattutto nel loro ambito, ma anche oltre, la stessa funzione delle teorie scientifiche, danno fondamento all’esser-ci. Rispondendo al desiderio di integrare nella storia una situazione primordiale non storica che pure direbbe ciò che è stato in principio, essi animano, nella singolarità di più codici, un gioco di analogie, di specchi, di reciproci riflessi che mai corrisponde ad un oggetto reale se non all’allusione al suo spettro significante.
Non si sa quanto poi essi possano riflettere dell’uomo la nostalgia di un legame più stretto con la Natura o l’angoscia del rischio di potersi alienare nel sempre nuovo.
Sta di fatto che, i mithologhemi, parlando per immagini e presentificandosi per rituali, rendono efficace e attuale il logos che vede e vuole l’uomo integrato nella sacralità di una poiesis cosmica senza che rinneghi la responsabilità verso se stesso ed il sociale.
Le loro risposte metastoriche alle domande sull’origine sono tali da dischiudere nuovi sensi e da questi altri ancora. Intessono un’ampia e sottile rete iconica capace di tenere rapportati lo spazio sacro delle ierogamie tra dei con le loro valenze cosmicizzanti e quello profano delle unioni sessuali tra uomini.
Queste sono per lo più deputate a perpetuarne la specie, ma ancor prima a favorire lo sviluppo cosciente di ogni Io nella interdipendenza destinale del maschile e femminile.
I mithologhemi, avvalendosi del simbolo – mai in senso assoluto, ma sempre in rapporto ad una totalità simbolica più ampia – parlano del salto nel mondo e dell’esserne presi e determinati; raccontano anche il bisogno tutto umano di capire quella forza che, immettendosi nelle opposizioni, rende possibile lo stesso divenire nella totalità delle relazioni prima naturali e poi culturali.
Sul presupposto di correlazioni semantiche, leggibili in una visione del mondo fondata su una religiosità naturale, mai esclusiva, essi tendono a rappresentare ogni origine nelle eterne immagini (archetipi). Queste vengono proposte all’ascolto ed alla ripetizione nei riti esistenziali e percepite non certo nella concretezza di un esteriore spazio e tempo del mondo empirico, ma in quello intimo della psiche, responsabile dello sviluppo ontogenetico della coscienza egoica.
Sull’onda di istanze definitorie che muovono da un presente ad un lontanissimo inafferrabile passato del passato, preludio del proprio esser-ci, a motivare e compensare i possibili vuoti di identità, si configura un incipit indifferenziato: Uroboros[4]; a cui segue un incipit di differenziazione: Grande Madre[5].
In quest’ultimo inizio l’Io, non del tutto fuori dalla fase uroborica, si dispone ad emanciparsi dall’inconscio nelle lotte eroiche dell’esser-ci, che gli consentono di conquistare innanzitutto i suoi spazi di realtà autonoma, definendosi nel maschile o nel femminile. Questa differenza è peraltro destinata a superare il suo originario significato biologico,diventando luogo simbolico cui rapportarsi nella ripartizione dei ruoli sociali.
Olre che nella differenza sessuale di un lui e di una lei, l’Io deve, in ogni modo, sperimentarsi, passando per la dinamica di processi maturazionali dalla doppia risultanza del distruttivo e del costruttivo. E ciò, sempre, sotto lo scudo della Grande Madre che, in quest’ottica, può apparirgli buona e terribile, signora della vita e della morte, della memoria e dell’oblio. quasi ad esorcizzarne la valenza negativa – causa anche delle insuperabili paure inconsce dell’uomo nei confronti della donna – l’idealità, non solo eroica, traduce in memoria collettiva l’evento della morte. Per ogni io che declina, cedendo in successione il proprio spazio biodinamico e fenomeno logico all’esser-ci di altri io, il ricordo risolve la disperazione dell’assenza nell’illusione culturale della presenza.
Del femminile, i misteri di creazione e nutrimento e gli stessi caratteri elementari di conservazione e di trasformazione, definiscono il corpo, fondamento di tutti gli eventi psichici, come quel numinoso[6] che, pur differenziandosi in una considerevole molteplicità di figure, conserva l’aspetto pulsionale ed istintuale della vita che continua a vivere in quella regolarità che è ripetizione dell’identico.
Della Madre – anche come terra ed in senso più lato come Natura – fluisce eternamente, nei frutti, la vena creativa del suo potere sacrale che diversi riti intendono comunque propiziarsi. In particolare, quello misterico delle Thesmoforie[7], consacrato da Demetra che veglia sulla fertilità delle donne e del territorio coltivato e che, nelle invocazioni rituali, è detta “generosa di cibo”[8].
Questa nativa “generosità” può venire meno nel momento in cui si fanno errori per comportamenti sviliti da inganno o sviati da impulsi contrastanti. Questi errori, commessi comunque per non-conoscenza, sono capaci di interrompere quella benvoluta correlazione euritmica o più semplicemente armonica tra naturale e culturale.
La Natura ne soffre, quindi, le conseguenze negative in una malattia che, nei sintomi, ha tutto il sapore d’essere la punizione di un dio, per il quale le ragioni del cuore, che la ragione non può non comprendere, devono accordarsi con quelle razionali cui è affidato l’ordine onto-teo-logico di quella realtà che, identica a se stessa, per esser-ci non ha bisogno di parole. “La terra è sconvolta…muorendo nei germogli fruttiferi, nelle mandrie che non generano, nei parti non avvenuti delle donne”[9].
Alla fecondità, sempre auspicata, si riferiscono le metafore, identità spesso “metonimizzate”, del solco e del campo arato[10], rievocate persino nella formula contrattuale delle nozze, al momento della stretta di mano dal padre allo sposo: “Ti do una figlia da arare”[11].
Tutte queste metafore sono rivolte alle donne che, nel concepimento e nel parto, imitano la terra[12].
Per Edipo, giunto a scoprire la verità, Giocasta, matrice sua e dei suoi figli, è “la femminea zolla due volte feconda”[13].
Della Madre i mithologhemi dicno e la nascita e la morte, fenomeni che sfuggono all’ordine del prevedibile, ritenuti – come le mestruazioni, il coito, il parto, il puerperio – tali da rendere impura la donna che ne celebra di persona i rituali. L’uomo ne è escluso per non essere contaminato. Di fatto all’impurità è connesso il contagio dal quale si esce coi riti catartici (purificatori) che ripristinano la possibilità interrotta di un rapporto con la divinità.
Morire è anche un ritornare alla Madre che come archetipo implica non solo una relazione di filiazione fisica, ma anche psichica, eternamente presente nell’inconscio collettivo che guarda a Lei come ad un Femminile onnipotente cui si è legati da sempre e per sempre nel ritorno.
Un inno orfico alla Physis riportato da Karoli Kerenyi, nel suo libro dice: “Natura! Noi siamo circondati ed avvinti dalla Natura, incapaci di uscirne ed incapaci di inoltrarci più profodnamente in lei. Senza esserne pregata ed ammonita, essa ci accoglie nel girotondo della sua danza e ci trascina con sé, finchè noi non ci stanchiamo e non caschiamo dalle sue braccia”[14].
Se si assecondano poi motivazioni emotivo-concettuali e non certo filologiche, tenta molto l’abusiva integrazione in clausola: “per ricadere nel suo grembo”.
E’ lento e difficile e per nulla indolore il distacco ombelicale dell’uomo dalla Madre Natura che gli Inni Orfici celebrano come “padre di se stesso e senza padre, splendida gioia ed infinita”[15].
Omero la chiama “potnia”, potente con termine preso da un’antica tradizione sacrale[16].; Saffo ne utilizza l’attributo divinamente in adonio, nella sua preghiera ad Afrodite, la dea che domina il mondo con gli incanti della seduzione: il desiderio, l’amore, la carezzevole persuasione.
In verità la Natura è la potente Madre che procrea instancabilmente e che è sempre pronta a riprendersi le sue creature per poi restituirle alla vita possedendole in questo modo sempre più. A lei vien voglia di adattare l’affermazione di Ibsen: Non si possiede eternamente che ciò che si è perduto”.
Infondo, che si voglia o no, le apparteniamo soprattutto nel non-esserci. Solo che Henrik Ibsen non parla il linguaggio degli dei greci. Anzi gli uomini dei suoi dramma – di ben altro contesto, definibile post-moderno anche per la pretesa emancipazione da ogni dialettica connessione con il passato – non sono più mossi dall’esigenza di edificare un propio io, governato da un’anima capace di accogliere quel desiderio di infinito leggibile nell’eterno ritorno dell’uguale. Nelle loro crisi di identità i suoi uomini sono invece irretiti entro l’alternativa di essere monadicamente se stessi o di non esserlo per niente.
Si logorano nella passività di una grigia esistenza simbolicamente dall’anitra selvatica che, imbalsamata, è pur non essendoci.[17]
Il femminile non si riconosce nel solo mythos della Grande Madre, il cui simbolo a dodona è la colomba afroditica nera come il buio grembo materno, come la terra umida e feconda, come la notte madre del giorno.
Nel mythos di Demetra e Kore il femminile assume valenze che mettono in crisi la priorità primordiale della sua maternità materiale, valorizzando il diritto del principio fecondatore, come dire il seme al solco. “Genera l’uomo che la feconda, lei, come ospite ad ospite, conserva il germoglio, se un dio non lo soffoca prima”[18]. E a dirlo non a caso è Apollo, il dio che impersona il principio di individuazione nel quale si esprime lo stesso esser-ci dell’essere sia maschile che femminile – pur nella condizione naturalmente privilegiata di quello rispetto a questo.
Articolo preso da erbafoglio, rivista di cultura poetica, anno X n.19/20, Luglio 1997.
[1] Mythològhema è un’esposizione le cui componenti mitiche, rispondendo ad esisgenze di esemplificazione razionale, seguono, all’interno del loro codice, concatenazioni logiche che dicono il senso e il non-senso delle cose.
[2] Platone, Fedro.
[3] Plat, Repubblica.
[4] Uròboro è un antico simbolo egiziano iconograficamente rappresentato dal serpente che si morde la coda,assunto dalla simbolica psicologia analitica come archetipo dell’indifferenziato che precede lo sviluppo della personalità e la differenziazione degli opposti, dacché prende avvio la dinamica psichica.
[5] Vedi: Erich Neumann, storia delle origini della Coscinza, Astrolabio Ubaldini, Roma, 1978; Erich Neumann, La Grande Madre, Astrolabio Ubaldini, roma, 1981.
[6] Termine coniato da Rudolf Otto (cfr Il Sacro. L’irrazionale nell’idea del destino e la sua relazione col razionale, Feltrinelli Milano, 1966) e ripreso da Jung per indicare quella qualità che l’uomo ha sperimentato con forte emozione come appartenere al divino.
[7] Festa in onore di Demetra (thesmoforia, legislatrice): duravano cinque giorni, dopo la semina d’autunno, e la dea vi è celebrata come istitutrice dell’agricoltura, del matrimonio e di tutto il vivere civile.
[8] Cfr, Callimaco, Inno a Demetra.
[9] Soph., Ed. Re.
[10] Cfr, Pindaro, IV Ritiro.
[11] Cfr, Menandro, Perikeiromène – Samia – Discolos.
[12] Cfr, Platone, Menesseno.
[13] Cfr, Soph, Ed. Re.
[14] Karoli Kerenyi, Miti e Misteri, Boringhieri, Torino, 1984.
[15] Cfr, O. Kern, Orph. Fragm., Berlin, 1922.
[16] Cfr., Hom.
[17] Mircea Eliade, Il Sacro e il Profano, Boringhieri, torino, 1984.
[18] Eschilo, Eumenidi.