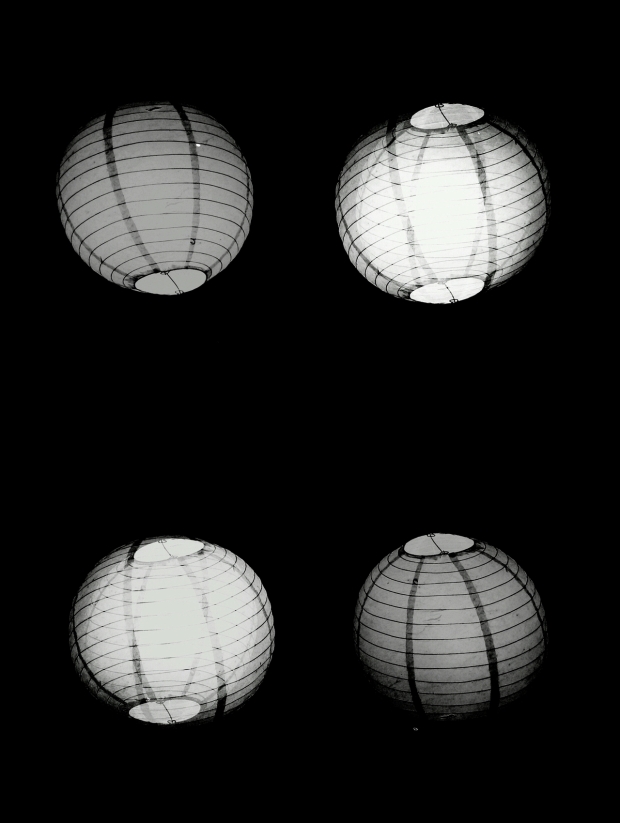in collaborazione con Critica Impura
http://criticaimpura.wordpress.com/
LE COLPE IMPUDICHE
di Meth Sambiase
E’ il giorno contro la violenza delle donne. Da vari anni, nel calendario italiano ed occidentale in genere, si stanno intensificando le orazioni celebrative dedicate ai pro o ai contro, alla memoria, alla salute, etc. Caviamo allora dall’almanacco di oggi, il giorno contro la violenza sulle donne, ma allontanandoci dalla geografia dei dati e dei convegni , che addensano questa data ma non la rivoluzionano, non sventrano i motivi della violenza rivoluzionando il dato “certo” per cominciare a ricercare le “cure certe”. Quindi, il limite di questo giorno, e di molti altri di questi giorni, è nell’accettare la natura del male, sensibilizzandosi nello sdegno o nel compiacimento dell’andamento dei vari insiemi grafici, ma lasciando inespressa la soluzione.

foto di Antonella Monzoni
La stratificazione millenaria della non colpevolezza maschile per lo stupro e per l’uso sistematico della violenza , beneficia generosamente dell’ immunità morale – quella stessa che fino a qualche spicciolo di tempo fa in questo Paese così pietoso di professione aveva nel codice il delitto d’onore – che finisce per impedire una rivoluzione legislativa e sociologica che imponga e definisca un’identità sessuale senza né vittime né carnefici giustificati. E’ nella continuità della visione debole della donna che nascono le variabili e croniche giustificazioni naturali\fisiologiche\morali\razziali\ sulla “naturalezza dell’esigenza” di predare da parte di non bene identificati maschi alfa una donna, femmina omega ma anche femmina zeta , se l’analfetizzazione di ritorno di questi tempi non consente di riconoscere l’omega-fine del mondo. E’ colpa del patriarcato, rispondono da alcune parti, anche dei movimenti femministi; è stato il patriarcato ad impedire di capovolgere la concessione “laica” della predazione della donna nel suo “naturale” opposto, il sacro tabù dell’inviolabilità. Patriarcato? Patriarca\il padre che vuole sapere di chi è\figlio che deve assomigliare al padre non solo alla \madre che alla fin fine è solo un’intercambiabile\donna. Non è così illogica la concatenazione.
Ma è un falso. Non è stato il patriarcato. E’ stato ancor prima della distinzione aristotelica tra uomini schiavi e donne, pensiero greco, pensiero genesi della filosofia occidentale. Sarà cominciato con la distribuzione della divinità nei simulacri delle statue? Sin, la Luna padre del tempio, Shamash, il Sole giudice del cielo e della terra, sono ugualmente uomini nella prima mitologia che ha lasciato tracce archeologiche, mentre la regina della terra, Ishtar è l’unica donna del pantheon semita. Nel suo tempio, vi erano due gradi di secerdotesse, le cosiddette “sgualdrine del tempio”, Qadischtu o Harimtu le sacre prostitute. Il sacro, riferimento per la costruzione del divieto, del tabù, viene quindi associato a cosa? alla prostituzione necessaria perché lo vuole da dea. Ti penetro in nome di quanto è più sacro, come potrebbe essere questo un tabù? E’ patriarcato? (un dettaglio specifico: non c’è concetto di proprietà privata come inviterebbe la sociologia del patriarcato).
Ergo non possono non essere consenzienti, le donne, non possono rifiutarsi, è sacrilegio. E’ fatta. Si continua a porre strati. La grande meretrice dell’Apocalisse seduta sulla bestia a sette teste (sette falli? numero perfetto?), “La donna che si spaccia per profetessa e insegna e seduce i miei servi inducendoli a darsi alla fornicazione” (Giovanni, 3:20). Indurre alla fornicazione: non è stato l’uomo che ha fornicato ma la donna che ha indotto alla fornicazione. La portata rivoluzionaria – per questa parte di civiltà occidentale – del messaggio evangelico, si arena subito, modificandosi sulla morale. Si può rispettare il corpo della donna a patto che essa sia in una convenzione, sia dall’indubbia morale: ipotizziamo: paziente rinunciataria, obbediente, passiva. Merce inutile, tutto sommato, roba di poco conto. L’ultima santa popolare è una bimbetta massacrata che “perdona” il suo assassino, Maria Goretti. Chiediamoci quale uomo massacrato e sodomizzato avrebbe perdonato il suo assassino. Niente di niente anche dalla Rivoluzione laica per eccellenza, quella delle idee illuminate, che transita e non passa sulle donne, “Jean-Jacques Rousseau, per certi versi filosofo della Rivoluzione, vedeva uomini e donne come creature separate, con diritti differenti” (H. C. Mansfield). Ma le rivoluzioni, seppur borghesi e maschili, non sono mai controllabili. Ed ecco, finalmente, una contestazione. A Rousseau risponde Mary Wollstonecraft, con il suo libro La rivendicazione dei diritti delle donne (1792). Passionale, ardente, propositivo. E’ cominciato il femminismo? Si, a ben vedere, finalmente. Ma le prime femministe (la citata Wollstonecraft ed Elisabeth Stanton) non si pongono il problema della violenza alle donne. Hanno la condizione femminile da dibattere, e la risolvono con la moralità. Anche la differenziazione tanto cara alla Beauvoir tra trascendenza (il crearsi) e l’immanenza (l’essere frutto della creazione degli altri) non regge interesse per la modifica delle regole del maschio alfa contro la violenza sulle donne. “Il secondo sesso” è un libro che con generosità d’idee e con coraggio, trascende la forma dell’iconografia femminile, ma è concentrato sul sesso. “Come si può conquistare l’indipendenza dal sesso? vi chiederete. La Beauvoir pensa che sia la passività della donna nell’atto sessuale a renderla un oggetto erotico per gli uomini e anche per se stessa, impedendole così di diventare un soggetto indipendente. E’ quindi nel sesso, e non nella debolezza delle donne o nell’aggressività degli uomini (quasi mai nominata dalla Beavoir) che l’autrice individua la causa principale dell’oppressione femminile” (H.C. Mansfield). Della grande triade di intellettuali femministe degli anni della “rivoluzione sessuale degli anni ‘Sessanta” in poi, Betty Friedman, Kate Millet e Shulamith Firestone, non arriva nemmeno qui una preoccupazione né ai maltrattamenti fisici né alla violenza sessuale E’ sotto esame la costruzione di una nuova identità femminile – si potrebbe obiettare – quindi si lasciano indietro porzioni di vita sociale che tutto sommato non toccano l'”insieme” delle donne, ma sono episodi isolati, sebbene cronicizzati. L’oppressione ha quindi due volti distinti? E in quale fascia d’attenzione si pone la differenziazione fra oppressione sociale e oppressione fisica? Sarebbe interessante lasciare i luoghi sociologici e ripartire da quelli corporali, il corpo sociale è un ossimoro, una definizione tanto vuota quanto piena di ogni pre-giudizio? Se indubbio sia il risultato di un peso maschile contro uno femminile sulla bilancia della forza fisica, la tara è nello scarto della giustificazione storiografica. Tagliare, troncare, sconsacrare quel pensiero “naturale” è il netto, la finalità del nuovo contro la coabitazione imposta della violenza. La Comunità Europea, nel 2000, in un rapporto (Rompere il silenzio) cita a proposito della violenza domestica “che essa è il sintomo più evidente dello squilibrio di poteri nel rapporto tra uomini e donne”. Trattandosi di linguaggio squisitamente politico, la nuova struttura della “comprensione e spiegazione” della violenza, diventa squilibrio di potere. Da pochi anni, ricordiamo, è nato un neologismo, femminicidio. Farà strada, è una nuova forma di “comprensione” per definire la natura del male. Anche il fenomeno delle Indignate è di natura politica, sebbene sia immesso nei lavori intellettuali per ridare dignità all’immagine della donna fuori dai nuovi ridicoli stereotipi del consumismo globale, che fanno leva sicura su quella immagine intercambiabile di sacra offerta. Fra i lavori in corso, quello di Loredana Lipperini, che nel suo libro “Ancora dalla parte delle bambine”, pone il problema anche dell’insufficiente attenzione verso la protezione dell’adolescenza da parte di una certa, incomprensibile, maternità che ha sposato appieno i valori dell’apparenza e del post-consumismo. Ancora oggi, il blog della giornalista è seguitissimo e fonte di spunti critici, ma la cifra sull’autodeterminazione sessuale della donna è fuorviante dalla domanda di cambiamento che in questo giorno si scrive. Sebbene una parte del nuovo femminismo americano abbia nuovamente preso la strada verso esso, dal quel valore “bellezza uguale desiderio” che Naomi Wolf, aveva messo a fuoco nel suo libro “Il mito della bellezza”, in cui spiegava che la bellezza è un mito imposto alle donne dagli uomini, e le donne ne sono ossessionate. Punto a suo favore: è vero. La Wolf, appena l’anno scorso, ha subito pesanti attacchi dalle femministe americane per il suo ultimo libro, “voci critiche mi accusano di essenzialismo – si difende la scrittrice – per aver ricacciato il genere del corpo. Una certa corrente ortodossa del pensiero femminista contemporanea sostiene che il genere sia sempre, ovunque e comunque “socialmente costruito”, vale a dire esistente solo negli schemi mentali o nei comportamenti mentali”. Se i comportamenti mentali derivati da schemi mentali sono ancora inattaccati, se l’abuso di un genere (e qui si ritorna allo schema della Beavoir) resta annesso nella concessione storica perché anche l’ortodossia femminista si frantuma nel suo potenziale rivoluzionario, allora è facile credere che questo giorno contro la violenza della donna, lo metteranno nel calendario fino alla fine dei tempi.

***
in collaborazione con Critica Impura
http://criticaimpura.wordpress.com/
SCRIVERE CON IL CORPO: Annemarie Schwarzenbach e il divenire mondo, una donna in viaggio oltre la modernità dissonante.
Di Antonella Pierangeli

In viaggio con le nostre biciclette e con la Ford, non cercavamo l’avventura, ma soltanto un attimo di respiro, in paesi nei quali le leggi della nostra civiltà non valevano ancora e dove speravamo di fare l’impagabile esperienza che queste leggi non sono affatto inevitabili, immutabili, indispensabili. Provate a immaginare: il tempo non contava! Gli orologi, i calendari erano superflui! E avevamo perfino trovato persone, contadini, nomadi per i quali il denaro non significava niente”
Annemarie Schwarzenbach, Kabul, 1939
Scrivere con il corpo è, nel caso di Annemarie Schwarzenbach scrittrice, fotografa e viaggiatrice instancabile, dare voce ad una necessità insopprimibile dell’anima prima ancora che concretizzare, attraverso la trasmigrazione della scrittura dal corpo nomade alla pagina, quella sorta di essenzialismo temporaneo che, in attesa di un tempo utopico in cui non sarà più possibile parlare del binarismo dominante uomo-donna, realizzi finalmente un linguaggio che distrugga partizioni, classi e retoriche, regolamenti e codici.
L’angelo devastato – così Klaus Mann ebbe a definire l’efebica, inquieta, Schwarzenbach – e le sue opere, in un Novecento così profondamente immerso in una palude di cultura maschile e maschilista, nella loro essenza di opera aperta, trovano pace soltanto nel turbine tattico del nomadismo intellettuale e geografico in cui si dividono, si fanno testimonianza, si vitalizzano in una proliferante – e questa volta sì – femminilità generativa. La sua assillante urgenza espressiva è decifrare, non importa se con la scrittura o con la macchina fotografica, quella che Genet chiama “la spaziosa carne cantante” sulla quale si iscrive non si sa quale Io, più o meno umano, ma sempre in via di trasformazione. La scrittura ribelle e nomade e il suo vagare nel mondo, basti pensare al bellissimo Dalla parte dell’ombra fino allo struggente Morte in Persia, è infatti l’unico luogo in cui la Schwarzenbach non è costretta a riprodurre steccati, in cui non deve piegarsi alle convenzioni familiari o sociali (che pure sconvolgerà con la sua vita anticonformista e assolutamente diversa, lei omosessuale, tossicomane, vagabonda eternamente in rivolta) ma è un altrove che scrive se stesso e che inventa altri mondi, anche scritti sul corpo, vivendo una sorta di trance erratica che non cancella le differenze, ma le anima, le persegue, le arricchisce. La sua avventura umana ed intellettuale che la spingerà insieme ad Ella Maillart fino in Afghanistan a bordo di una vecchia Ford, e che darà vita allo stupendo La via per Kabul, è una assoluta incarnazione di fierezza e coraggio di donna nello spento mondo della vecchia Europa abbrancata dallo spettro del Nazismo. Nella sua erranza di donna trova fondante, per riappropriarsi della propria identità, lo scrivere di se stessa e di quello che chiama “l’ascolto del proprio corpo in stato di grazia” e tale tattilità simultanea segna l’emergere dell’Io scrivente, non l’appiattirsi nella scrittura di genere. In questo modo la parola diviene, nell’asessuato trionfo della scrittura, carne linguistica, materia organica, scrittura dei vuoti, delle cadute e dei silenzi. Che poi la mano che muove la penna sia di una donna, non possiamo considerarlo soltanto un puro accidente…

“Situarsi in un posto nel mondo” è ciò che Annemarie vuole fare, appunto, scrivendo e viaggiando in quelle che lei chiama “cartografie della mente”, che sono poi mappe del suo pensiero errabondo, della sua randagìa esistenziale, ricostruibili dal luogo parziale dal quale lei stessa si guarda attorno. Nel suo desolato vagare, invita il lettore a considerare il suo viaggio “corporeo” come una mappa attraverso cui orientarsi e questa mappa ha un perno che nemmeno Annemarie immagina sarà così unico e irrinunciabile: fare della differenza – sessuale, culturale, esistenziale – qualcosa di positivo e creativo, sottraendola a quella tonalità negativa che le deriva dal fatto che ogni differenza, in un mondo dominato dalla logica del dominio maschile, è l’Altro, il che poi significherebbe che una donna è l’Altro dell’uomo, che lo straniero è l’Altro del cittadino socialmente riconosciuto e così via. Nella sua ricerca disperata della liberazione dal proprio ruolo, la viaggiatrice inquieta Annemarie ha un’unica domanda scritta sul corpo e quindi nella carne: come fare di questa differenza, anche se desolata e dissonante, qualcosa che apra uno spazio di soggettività intensiva, di aumento della consapevolezza e della percezione dell’essere?
La sua scrittura – nel costruire nuove pratiche di liberazione attraverso la sua vorticante espressività – finisce così per essere la forza che scombina la linearità dei procedimenti e delle pratiche di sopraffazione di un mondo profondamente violento e castrante, quello della ferinità maschile, che Annemarie aborre e fugge, mettendo in evidenza nelle sue opere come il “divenire donna”, contraddizioni, paradossi, punti di non ritorno compresi, crei e rigeneri la passione della libertà, la dignità, la giocosità e perfino la leggerezza dell’essere. Il suo viaggio iniziatico riguarda infatti una corporeità in divenire che va oltre i confini dell’Io e che la lega, come donna, in una rete di incontri con multipli altri, dove parti di sé contaminano e influenzano altre parti di sé. Il suo viaggio verso ciò che lei stessa definisce “la modernità” è, dunque, l’opera aperta per eccellenza come la scrittura e il corpo sono, appunto, la matericità dell’opera. Un materialismo corporeo di donna, immanente, finalmente, si sottrae così al “fallologocentrismo” sociale, aberrazione della volontà che sta ad indicare ogni forma di dominio regolativo e di potere, di matrice maschile.
Ora proprio la figura della Schwarzenbach, androgina, eterea e in metamorfosi, è l’altro grande punto di forza del libertario e dissonante viaggio della scrittura verso la consapevolezza della sua forza: il divenire donna senza più padroni equivale infatti al divenire materia senza forma, che disgrega le identità per aprire a strade ambigue e nomadi. Così come le nevrosi di Annemarie fanno del suo corpo un relais di una rete tra umano e inumano, anche in questo contesto la sua opera apre un conflitto con l’immaginario maschile che, da sempre spaventato dal femminile per la sua materialità concreta e simbolica al medesimo tempo, si difende ricacciandolo in una dimensione di follia e di adimensionalità storica: Annemarie è infatti malata di mente, dunque condannata all’oblio dalla stessa maschilista scienza medica. Ma proprio in quel preciso istante in cui si emette la condanna al mutismo forzato e alla forzata pace interiore, le angosce che emergono come fantasmi fluttuanti dalla mente di Annemarie incidono nel suo destino i segni dell’affiorare di nuove possibilità del divenire. Sono infatti i luoghi ambigui che, nel reale della memoria, aprono tracce impreviste: la Persia favolosa percorsa in notti senza tempo, la materia senza forma della felicità di un istante fluttuante come le tende berbere in Turchia, la perdita di confini corporei nella notte cagliata di Kabul, lo sdoppiamento identitario, durante una festa in costume, con il cuore colmo di seduzioni sottili e di odalische impertinenti.
Annemarie Schwarzenbach è, dunque, veramente una creatura eccezionale. Attraverso le sue pagine, racconta la sua inesauribile voglia di sapere, capire o meglio comprendere la vita, il tutto con un’intensità tale da farci sentire una specie di richiamo, un urlo di libertà emergere dalle sue parole. Per anni dimenticata, caduta nell’oblio e oggi più che mai attuale. Una donna tra gli uomini del suo tempo, diversa, ribelle, il suo sguardo e la sua luce poetica a conferirle una posizione particolare nel mondo. Un’osservatrice attenta, dallo sguardo perspicace e rivelatore. Spinta dalla sua vita privata non facile, in un momento storico peculiare e indimenticabile come quello popolato dagli spettri del nazismo, Annemarie viaggia dunque disperatamente, tentando voracemente la fuga dalla sua gabbia dorata e dal suo ruolo di figlia. Proprio il viaggio è filo conduttore della sua poetica, una sorta di commutatio loci, in realtà anche terza via di fuga di fronte ad una scelta difficile tra una famiglia devota all’ideologia nazista ed un legame, quello con i fratelli Mann ed in particolare con il suo amore infelice Erika, di rotta contraria. Annemarie sembra votata alla distruzione, donna sempre in lotta e in fuga ma con forza sovrumana intraprende il suo percorso iniziatico alla ricerca della propria identità, verso la libertà, il buio e la vita.

Sono vicende umane, plasmate da un coraggio che conduce a sentieri impensabili. E’ proprio questo che la induce a dire, di fronte al deserto, in Afghanistan, in una notte senza stelle: “Si dovrebbe poter diventare un pezzo di deserto e un pezzo di montagna, e una striscia di cielo di sera. Ci si dovrebbe affidare a questo paese e disfarsi in esso. Vivere contro è una tale impresa che si muore di angoscia.”
http://www.youtube.com/watch?v=N6kbfB_e7BI&feature=relmfu
***
in collaborazione con Critica Impura
http://criticaimpura.wordpress.com/
Nel paradiso dei poeti Rilke incontra Susana Chavez e …
di PINA PICCOLO
[..]un giorno vi sarà la fanciulla, e la donna, il cui nome non significherà più solo un opposto al maschile, ma qualcosa di proprio, qualcosa che non induca a pensare a complementi e confini ma soltanto a esistenza e vita: la creatura femminile.
Questo progresso trasformerà (dapprima assai contro la volontà dei maschi superati) l’esperienza dell’amore, che adesso è piena di errore, la cambierà dalla radice, la muterà in una relazione che è intesa da uomo a uomo, non più da maschio e femmina. E questo amore più umano (che si compirà infinitamente attento e lieve, e buono e chiaro nel legare e sciogliere) somiglierà a quello che noi lottando e con fatica andiamo preparando, l’amore che consiste in questo: che due solitudini si proteggano, si limitino e si inchinino l’una innanzi all’altra. [Rainer Maria Rilke, Lettera a un giovane poeta, 14 maggio 1904]
SANGUE NOSTRO
Sangue mio,
di alba,
di luna tagliata a metà
del silenzio.
della roccia morta,
di donna in un letto,
che salta nel vuoto,
Aperta alla pazzia.
Sangue chiaro e nitido,
fertile e seme,
Sangue che si muove incomprensibile,
Sangue liberazione di se stesso,
Sangue fiume dei miei canti,
Mare dei miei abissi.
Sangue istante nel quale nasco sofferente,
Nutrita dalla mia ultima presenza.
[Susana Chavez, Traduzione di Valeria Campilongo, poesia tratta dalla rivista letteraria Sagarana http://www.sagarana.net/anteprima.php?quale=319 ]

foto di Antonella Monzoni
Nell’epoca di Lady Gaga e di personaggi e pratiche che presumibilmente incarnano il superamento del femminismo in seguito a una sedicente realizzazione delle sue rivendicazioni, il termine “fanciulle” contenuto nella lettera di Rilke, per il suo sapore arcaico, e la scelta di “uomo” per indicare persona, potrebbero suscitare in noi un moto di stizza. Tuttavia la sostanza liberatoria di quel prognostico a oltre cento anni dal suo proferimento è ben lungi dall’aver trovato attuazione, in nessun angolo della terra, compresi i paesi “nordici”. I rapporti tra uomo e donna hanno, nella maggioranza dei casi, continuato ad essere governati da errore e non manifestano quella leggerezza e attenzione auspicate dal poeta tedesco. Dal Messico all’Italia basta aprire i giornali per rendersi conto delle dimensioni della crisi tra uomini e donne. La resistenza del maschio al cambiamento, giustamente sottolineata da Rilke, si esprime in una gamma di comportamenti che vanno da piccoli tiranneggiamenti quotidiani alla violenza esplosiva che lascia donne e ragazze morte sul campo.
Dal controcanto di Susana Chavez, in apparenza più attuale, alimentato com’è dall’ immagine del sangue creata dalla poeta/attivista vittima di femminicidio a Ciudad Juarez, la città sprofondata a simbolo dell’uccisione di massa delle donne, si intuisce un ulteriore ammorbamento dei rapporti uomo-donna. Nella denuncia poetica si concretizza allo stesso tempo la determinazione a uscire dal silenzio. Al grido di “No una mas”, le donne di Ciudad Juarez da anni chiedono la solidarietà di tutte/i, esponendosi in prima per persona per porre fine a questo stato di cose. Questa rivolta si è estesa e ha portato all’adozione del termine femminicidio in moltissimi paesi del mondo per indicare l’uccisione di donne e ragazze quale eliminazione di “femmine” che cercano di liberarsi da un ruolo subalterno. Un’ulteriore svolta è stata l’istituzionalizzazione di una giornata, il 25 novembre, dedicata a livello internazionale a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza contro le donne, la cui massima espressione è il femminicidio. E proprio in questa giornata mi piacerebbe immaginare l’incontro tra Susana Chavez e Rilke, nel paradiso dei poeti. Me li immagino come Damiel e Cassiel de “Il cielo sopra Berlino” dialogando, invisibili, su un autobus che percorre la periferia di una qualsiasi grande città del mondo.
E di che parlerebbero? La poesia e il femminicidio possono sembrare argomenti lontani tra di loro anni-luce ed è quindi lecito chiedersi come possa la poesia contribuire ad arginare questa fiumana di sangue. Ai due “angeli a questo punto potrebbe aggiungersi Lorenzo Calogero, poeta di grande talento ma poco conosciuto , a differenza di Rilke escluso dall’amore e forse morto suicida che in uno dei suoi 804 quaderni di riflessioni poetiche, filosofiche e mediche affermava, “La poesia potrebbe essere definita come il modo con cui si realizza della vita e poiché il più alto vertice della vita è il sentimento amoroso si comprende come essa potrebbe essere definita come niente altro che il modo dell’amore[..]” Ripensando al rapporto poesia/femminicidio, i tre potrebbero discettare sul fatto che oltre a rendersi veicolo per rompere il silenzio denunciando con passione l’esistente, la poesia potrebbe fare leva sulla sua capacità di mettere in contatto concetti, spazi, elementi che nella logica lineare, quella che comanda il nostro prosaico vivere quotidiano, stanno su piani diversi e irreconciliabili. La contiguità di suoni apre la porta a suggestioni e commistioni che mai potrebbero essere generate dal linguaggio discorsivo, legato alla “concretezza” dell’esistente, a una sua presunta “naturalezza” e immutabilità. Le immagini e metafore che formano il tessuto della poesia possono rafforzare l’anelito a un modo di rapportarsi diverso, possono scardinare l’ineluttabilità dei rapporti storici ed attuali. Anche se la poesia non è costituita che da suoni e silenzi, essa può svelare mondi e possibilità da attuarsi anche a piccoli passi nella vita quotidiana, nei rapporti tra uomo e donna, anche quelli che non siano di natura amorosa. I tre potrebbero ricordare che non a caso tra le diverse arti è proprio nella poesia che l’amore ha trovato il veicolo migliore per essere espresso, basti pensare alla vasta produzione incentrata sull’amore che caratterizza le origini della poesia in area italica e francese, la sua importanza nella poesia araba e persiana. E si auspicherebbero tra i poeti vivi la ripresa di una ricerca e sperimentazione poetica che esplori nuovamente questo sentimento.
Mi raccontava un mio amico poeta e giornalista che da anni vive con i Rom che nei suoi vari tentativi di organizzare laboratori di poesia tra i Rom in Kosovo e in Serbia, a sua grande sorpresa, le uniche poesie generate da queste popolazioni che vivono in situazioni durissime erano poesie d’amore. Il mio amico si aspettava poesie piene di rabbia e di denuncia e invece loro riferivano che l’astio e la durezza riempivano i loro giorni, per la poesia riservavano un altro combustile ed era l’amore. Guidati da una sorta di caparbietà nel voler preservare un nucleo di purezza in quello spazio sentivano l’esigenza di metterci dell’altro. Un anelito appunto di cambiamento. Allora alla discussione dei tre poeti, potrebbero aggiungersi anche le considerazioni degli aspiranti poeti tzigani.
Per finire incorniciando in maniera più compiuta queste riflessioni sperando di alimentare ulteriori spunti e pensieri vorrei proporre di nuovo parole di Rilke e di Susana Chavez, mondi e stili che possono sembrare irreconciliabili, ma che si ritrovano a praticare l’arte della poesia incarnati in sessi, secoli e condizioni che non potrebbero essere più diversi. Se avessero avuto oggi la facoltà di dialogare fra di loro immagino potrebbero dar luogo a vulcaniche commistioni poetiche in grado forse di rischiarare i tortuosi sentieri che ci si aprono davanti.
“Questo è il paradosso dell’amore fra l’uomo e la donna: due infiniti si incontrano con due limiti; due bisogni infiniti di essere amati si incontrano con due fragili e limitate capacità di amare. E solo nell’orizzonte di un amore più grande non si consumano nella pretesa e non si rassegnano, ma camminano insieme verso una pienezza della quale l’altro è segno.”
Rainer Maria Rilke
DONNA ASCIA
Donna
lontana,
improbabile
mascherata di ragione,
forza senza sangue.
Piccola incantatrice nata dalle sue tempie
che chiamano dubbio.
Profondità dell’intimo che non conosce maniere
accattivante con i suoi silenzi.
Atroce,
irresistibile, il desiderio di mordere la notte
che barcolla tra delusioni
impreziosita da racconti
immobile nella distanza.
Donna istante,
ascia
che trascini,
che tagli lingue e le spargi
nella mano di Dio che si contorce dalle risate con te.
Fuggitiva dalla tua cattura andrò via
sapendo perfettamente
che sei invincibile.
Susana Chavez [traduzione di Valeria Campilongo, tratta dalla rivista Sagarana http://www.sagarana.net/anteprima.php?quale=319%5D